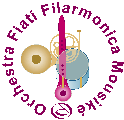Musica e Memoria Musica e Memoria
“modi di ricordare”
"Ma perché non fai tu guerra più aspramente
contro questo despota sanguinario, il Tempo?"
(Shakespeare)
"Se dorme ogni musica, morte conduce le danze"
(Spenser)

I vari “modi di ricordare” sono il
filo conduttore del programma 2007, che di volta in volta potrà essere
“montato” in modo diverso (la somma dei tempi di tutti i brani esorbita
infatti dalla normale durata di un concerto).
Musica e memoria: è abbastanza facile
mettere in rapporto il mondo dei ricordi con quello dei suoni. Entrambi
sono una forma di coesistenza colla tirannia del tempo, ne sfruttano la
capacità “dinamica” di non essere mai esattamente uguale a sé stesso (e
quindi di poter avere “delle storie da raccontare”) e lottano per non
sprofondare nella sua corsa verso il nulla. Entrambi, come un fiume
carsico, scompaiono per poi riapparire a distanza; si muovono in
faticose salite e precipitose discese – come i vagoncini delle montagne
russe. Nella realtà possono aspirare solo a successi parziali: fa parte
delle ipotesi paradossali (e dell’immaginario Funes di J.L. Borges) la
capacità di ricreare colla memoria a distanza di anni intere giornate
passate (e per ricordare esattamente una giornata passata occorre
esattamente una giornata presente). Ma, proprio per questo, musica e
ricordi non “tacciono” mai definitivamente. Le intermittenze (dei
sentimenti, dei ricordi, dei suoni…) sono poi anche la caratteristica
della storia della musica per quelle che oggi chiamiamo orchestre di
strumenti a fiato e percussioni (e che una volta erano semplicemente “la
banda”): dalla “propaganda” militare, civica e religiosa, all’esecuzione
per tutti delle musiche altrimenti destinate a pochi (le trascrizioni
delle opere), alla formazione dei giovani (e al “riscatto” dei meno
giovani – “grazie Signora Thatcher”…), all’ambiziosa volontà di
ricercare per uno strumento ormai tecnicamente maturo la piena dignità
di musica “d’arte” – e questo proprio quando il più immediato
riferimento (l’orchestra sinfonica) ha cessato di essere destinatario
abituale della musica non “di consumo”.
Ricordo come celebrazione e
ufficialità. Le pubbliche cerimonie hanno sempre richiesto
l’accompagnamento musicale: per le situazioni all’aperto erano d’obbligo
gli strumenti a fiato (e la “banda turca” delle percussioni non guastava
di certo). Gioacchino Rossini scrisse la Fanfara per la Corona
d’Italia (durata: 3 minuti ca.) in occasione della nomina a
Cavaliere di Gran Croce della Corona d’Italia: il brano (che associa il
tipico virtuosismo strumentale rossiniano al gusto per un suono “chiaro”
caratteristico della strumentazione ottocentesca per banda) venne
eseguito in presenza dell’autore e del re da numerose bande militari,
per un totale di oltre 100 esecutori. L’opera fu riscoperta nel 1978
nella biblioteca del British Museum da William A. Schaefer (uno dei più
autorevoli studiosi della musica per fiati), che ne ha curato l’edizione
moderna col titolo di “Scherzo for band”.
Tra gli incerti delle pubbliche
esecuzioni, soprattutto se “il livello musicale del pubblico è ancora
quello in cui non ci si interessa affatto al compositore, né alle
composizioni, e buona parte delle persone non si pone neppure la
questione se qualcuno si occupi di scrivere le musiche” (la citazione è
dalle Memorie di Rimski Korsakov!), è quello dell’insuccesso di un’opera
predisposta dall’autore con la massima cura: nel 1904 le cronache
norvegesi riportano che alla prima esecuzione nel 1904 della Valdres
Marsch di Johannes Hanssen abbiano applaudito solo due
persone (amici dell’autore, ovviamente…). Ciò non ha peraltro impedito
alla breve composizione (4 minuti ca.) di entrare poi con grande
successo in repertorio. Valdres è una regione norvegese circa a metà
strada tra Oslo e Bergen: nello spirito delle “scuole nazionali” di fine
Ottocento, la marcia utilizza antiche melodie e modi strumentali
popolari (tra cui la “sigla” della fanfara del Battaglione di Valdres).
In onore di un’area geografica è stato
concepito anche il “trittico sinfonico” Al Piemonte del
compositore romano Carlo Alberto Pizzini; in questo caso, al
ricordo “originario” (la celebrazione della storia e dei “primati” della
regione che fece nascere il Regno d’Italia e la FIAT, e questo in un
momento storico del tutto particolare, il 1940) si aggiunge la “nuova”
memoria della riscoperta di una composizione presente nel repertorio
internazionale, ma pressoché sconosciuta al pubblico italiano.
L’interesse supera nettamente la mera curiosità; se la titolazione
rimanda al sinfonismo (e straordinario mestiere strumentale) di Respighi,
un ulteriore elemento del Novecento italiano (l’amore futuristico per la
“musica delle macchine”) fa capolino nell’ultimo dei tre “pannelli” che
si susseguono senza interruzioni (durata circa 12 minuti) e con una
“ciclica” ripresa finale dell’iniziale motivo di fanfara: Insegne
gloriose, Notturno sulle alpi e Macchine e cuori (le
fonderie della Fiat).
La commissione nel 1989 da parte di un
grande complesso (la banda dell’Aviazione americana) a uno dei più
rinomati e accademicamente riconosciuti autori nazionali, James
Barnes, di una nuova grande composizione (addirittura una Terza
Sinfonia op. 89) avrebbe potuto produrre come risultato musiche di
grande “confezione” e di altrettanta freddezza; se questo non è
assolutamente avvenuto è anche per l’emergere drammatico di memorie
personalissime del compositore: l’elaborazione del lutto per la morte
della figlia Nathalie. I quattro tradizionali movimenti della sinfonia
(eseguibili anche singolarmente, rispettivamente di circa 14, 6, 13 e 7
minuti) vogliono infatti rappresentare un percorso dal buio della
disperazione alla luce della rinascita e della riconciliazione, partendo
dall’inizio “informale” del primo movimento (Lento – Allegro ritmico),
attraverso l’intermezzo del secondo (uno Scherzo non tanto per la
forma musicale e lo spirito, ma per il gusto ritmico “alla Stravinski” e
il melodizzare tipicamente “anglosassone” alla Vaughan Williams). Cuore
della composizione è la Fantasia per Nathalie (“fantasia sul mondo in
cui è vissuta Nathalie; il mio Addio per lei”), dove espansioni
melodiche con l’enfasi del pieno organico si alternano a delicatissimi
carillons e bicinia strumentali; il finale (Allegro giocoso)
alterna temi di fanfara a episodi “corali” di semplice armonizzazione e
distesa cantabilità.
Approcci completamente diversi
caratterizzano due brani di recente composizione come In Memoriam
di David Maslanka (durata circa 15 minuti) e October di
Eric Whitacre (8 minuti circa). Il primo brano è stato commissionato
dalle associazioni goliardiche Kappa Kappa Psi e Tau Beta Sigma
dell’Università del Texas in ricordo di Susan Eck, moglie di Ray
Lichtenwater, direttore delle bande universitarie. La “memoria” musicale
di un corale bachiano (Wer nur den lieben Gott laβt walten)
diviene lo spunto per un’elaborazione che mira alla ricerca di nuovi
linguaggi attraverso utilizzi anche inusuali degli strumenti; le ampie
“variazioni-fantasia” terminano però in un clima di calma forza, in
accordo al testo dell’inno secentesco: “Se ti affidi alla guida di
Dio / e poni in Lui la tua fiducia / sempre L’avrai al tuo fianco / a
darti speranza e forza. / Coloro che si affidano all’immutabile amore di
Dio / costruiscono sulla salda roccia”.
Nel secondo brano l’evocazione
musicale del mese di ottobre (che non è certo “il più crudele dei mesi”
di una ... Landa desolata) si appoggia a semplici melodie
ispirate ai romantici inglesi (viene da pensare a Elgar e Vaughan
Williams); nelle parole dell’autore “ho dovuto lavorare duramente per
scrivere un brano che potesse essere eseguito da tutti e 30 i licei
[che si erano associati nel reperire i fondi per commissionare il brano]
senza comprometterne la qualità musicale: in verità, scrivere musica
‘facile’ è stato una delle cose più difficili, ma sono decisamente
felice del risultato, perché non c’è mai abbastanza ‘bella’ musica per
fiati”.
Il cerchio si chiude sui vagoncini
dell’otto volante di Dereck Bourgeois: Roller Coster,
commissionato nel 2000 come brano di apertura (“di riscaldamento”) per
la partecipazione a un concorso bandistico internazionale, è dall’inizio
alla fine (per circa 7 minuti) una rincorsa virtuosistica ininterrotta e
mozzafiato.
Biografie brevi
|
 James Barnes (1949) è docente
di orchestrazione, composizione e storia della musica per fiati
all’Università del Kansas, essendo stato per 27 anni direttore associato
delle bande universitarie (oltre che eccellente strumentista di tuba).
Le sue composizioni sono regolarmente presenti nelle più prestigiose
sale da concerto statunitensi e per la sua attività è stato più volte
premiato (“Ostwald”, ASCAP, “Kappa Kappa Psi”, “Bohumil Makovsky”),
ricevendo commissioni da tutte e cinque le principali Bande militari
USA; come direttore è ospite delle migliori orchestre a fiato mondiali
(Tokyo Kosei, Koninklijke Militaire Kapel…). James Barnes (1949) è docente
di orchestrazione, composizione e storia della musica per fiati
all’Università del Kansas, essendo stato per 27 anni direttore associato
delle bande universitarie (oltre che eccellente strumentista di tuba).
Le sue composizioni sono regolarmente presenti nelle più prestigiose
sale da concerto statunitensi e per la sua attività è stato più volte
premiato (“Ostwald”, ASCAP, “Kappa Kappa Psi”, “Bohumil Makovsky”),
ricevendo commissioni da tutte e cinque le principali Bande militari
USA; come direttore è ospite delle migliori orchestre a fiato mondiali
(Tokyo Kosei, Koninklijke Militaire Kapel…). |
|
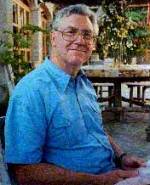 Derek Bourgeois (1941),
inglese, si è laureato con lode e menzione d’onore all’Università di
Cambridge, ottenendo poi il dottorato; al Royal College ha studiato
composizione con Herbert Howells e direzione con Sir Adrian Boult. Il
suo catalogo comprende sinfonie, concerti, altri brani sinfonici e
sinfonico-corali, opere e numerose composizioni cameristiche, nonché
brani per complessi di fiati e di ottoni, oltre che musiche per
programmi televisivi. Dal 1984 al 1993 è stato direttore dell’Orchestra
nazionale giovanile del Regno Unito; direttore principale dell’Orchestra
filarmonica di Bristol dal 1990, dal 1993 presiede la londinese St.
Pauls’s Girls’ School. Derek Bourgeois (1941),
inglese, si è laureato con lode e menzione d’onore all’Università di
Cambridge, ottenendo poi il dottorato; al Royal College ha studiato
composizione con Herbert Howells e direzione con Sir Adrian Boult. Il
suo catalogo comprende sinfonie, concerti, altri brani sinfonici e
sinfonico-corali, opere e numerose composizioni cameristiche, nonché
brani per complessi di fiati e di ottoni, oltre che musiche per
programmi televisivi. Dal 1984 al 1993 è stato direttore dell’Orchestra
nazionale giovanile del Regno Unito; direttore principale dell’Orchestra
filarmonica di Bristol dal 1990, dal 1993 presiede la londinese St.
Pauls’s Girls’ School. |
|
Johannes Hanssen
(1874-1967) fu uno tra i più attivi direttori di banda, compositori e
insegnanti norvegesi nella prima metà del secolo scorso; dal 1926 al
1946 (con l’interruzione del periodo bellico) è stato direttore della
Banda militare di Oslo, essendo pure contrabbassista nelle orchestre del
Teatro e della Radio nazionale. La maggior parte delle sue composizioni
bandistiche giace tuttora inedita presso l’archivio della Banda
militare. |
|
 David Maslanka (1943) ha
studiato composizione all’Oberlin College con Joseph Wood, laureandosi
all’Università del Michigan con H. Owen Reed, avendo inoltre studiato
per un anno presso il Mozarteum di Salisburgo. Nel suo catalogo, che
comprende anche brani cameristici, sinfonici e corali, particolarmente
note sono le composizioni per orchestra di fiati e percussioni sole. David Maslanka (1943) ha
studiato composizione all’Oberlin College con Joseph Wood, laureandosi
all’Università del Michigan con H. Owen Reed, avendo inoltre studiato
per un anno presso il Mozarteum di Salisburgo. Nel suo catalogo, che
comprende anche brani cameristici, sinfonici e corali, particolarmente
note sono le composizioni per orchestra di fiati e percussioni sole.
|
|
Carlo Alberto Pizzini
(1905-1981) studiò con Cesare Dobici e Ottorino Respighi, diplomandosi a
Bologna nel 1929 e perfezionandosi poi con Respighi all’Accademia di
Santa Cecilia, dove fu premiato nel 1931 come migliore allievo.
All’attività di compositore (brani sinfonici, cameristici, corali,
musiche di scena e da film) unì non solo quella di direttore (Europa,
Giappone, Irsaele e America), ma anche di organizzatore musicale,
ispettore S.I.A.E. e funzionario RAI. |
|
 Gioacchino Rossini: seriamente,
vi aspettavate di trovarne qui la biografia? Gioacchino Rossini: seriamente,
vi aspettavate di trovarne qui la biografia? |
|
 Eric Whitacre (1970) è
uno dei più noti compositori di musica corale e per orchestre di fiati
della sua generazione; ha studiato con John Corigliano alla Julliard
School, dove ha conseguito il Master. Le sue musiche hanno ricevuto
numerosi riconoscimenti statunitensi (“Harord Arlen”, “Barlow”,
Associazioni dei Compositori e dei Maestri di coro…); come direttore si
è prodotto in tutto il mondo con ensembles sia professionali che
universitari. Eric Whitacre (1970) è
uno dei più noti compositori di musica corale e per orchestre di fiati
della sua generazione; ha studiato con John Corigliano alla Julliard
School, dove ha conseguito il Master. Le sue musiche hanno ricevuto
numerosi riconoscimenti statunitensi (“Harord Arlen”, “Barlow”,
Associazioni dei Compositori e dei Maestri di coro…); come direttore si
è prodotto in tutto il mondo con ensembles sia professionali che
universitari. |
 Music and Memory
Music and Memory
"ways of remembering"
"But wherefore do not you a
mightier way Make war
upon this bloody tyrant, Time?"
(Shakespeare)
"When all musicks sleep, Death
doth leade the Dances"
(Spenser)
The different “ways of
remembering” are the thread of the 2007 program, that shall be assembled
in different ways time by time, being the total duration of the pieces
longer than a standard concert.
Music and memory: it is quite
easy to relate the world of memories to the world of sounds. Both of
them are a kind of coexistence with the tyranny of time, they exploit
their “dynamic” capacity of never being exactly similar to themselves
(and to have therefore stories to tell), and fight not to sink in the
run towards nothing. Both of them, like a Karst river, disappear and
then reappear at a distance; they move in fatiguing climbs and
precipitous descents – like the wagons of a roller coaster. In reality,
they can aim only to partial successes: it is part of the paradox
hypotheses (and of the imaginary Funes of J. L. Borges) the capacity to
recreate with memory, after years, entire passed days (and in order to
remember exactly a passed day a whole present day is necessary). But,
exactly for this, music and memories are never definitively keeping
silent. Intermittences (of feelings, of memories, of sounds…) are
moreover the characteristic of the music history for what we actually
use to call wind and percussion orchestras (and that were once, simply,
the “band”): from military, civic and religious “propaganda”, to the
execution of musics normally destined to an elite (transcription of
operas), the forming of youth (and the “redemption” of not so young
people – “thank you Mrs. Thatcher” …), to the ambitious will to look for
the full dignity of “art music” for a fully-grown instrument – and this
exactly when the closer referent (the symphonic orchestra) ceased to be
the usual consignee of the “not consumption” music.
Memory as celebration and
official character. Public ceremonies always requested a musical
accompaniment: for the open air situations the wind instruments were
compulsory (and the percussions “Turkish band” wasn’t an inconvenience
at all). Gioacchino Rossini wrote the Fanfara per la Corona
d’Italia (duration: about 3 min.) on the occasion of the nomination
as Cavaliere di Gran Croce della Corona d’Italia: the piece (associating
the typical instrumental virtuosity to the taste for a “bright” sound,
characteristic of the 19th century band instrumentation) was performed
at the presence of the author and of the king from several military
bands, for a total of more than 100 players. The piece was rediscovered
in 1978 in the British Museum library from William A. Schaefer (one of
the most influential wind music historian), who took care of the modern
edition with the title of “Scherzo for band”.
Beside the uncertain of public
performances, above all if “the musical level of the public is as you
don’t care at all neither about the composer, nor about the piece, and
the most part of the people don’t even have the doubt that someone takes
care of writing the music” (quotation from the Memories by Rimski
Korsakov!), is the failure of a piece predisposed by the author with
extreme care: 1904 the Norwegian chronicles relate that the first
performance of the Valdres Marsch by Johannes Hanssen was
applauded only by two persons (author’s friend, of course …). This did
not prevent that the short piece (about 4 minutes) was included with
large success in the standard repertory. Valdres is a Norwegian region
located between Oslo and Bergen: following the spirit of the “national
schools” of end of the 19th century, the march uses old melodies and
folk instrumental modes (among them the fanfare “theme” of the Valdres
battalion).
Dedicated to a geographical
area is also the “Symphonic tryptic” Al Piemonte of the composer
Carlo Alberto Pizzini; in this case, besides the “former” memory
(the celebration of history and of the region’s primates that created
both the Italian Kingdom and the FIAT in a very particular historical
moment, in 1940), a new memory is added, the “new” memory of the
discovery of a piece already present in the international repertory, but
mostly unknown to the Italian public. Interest is prevalent to simple
curiosity; if the title reminds to symphonic nature (and exceptional
instrumental craft) of Respighi, a further element of the Italian 20th
century (the futuristic love for the “music of machines”) peeps in in
the last of the three movements, following one another without stops(
duration about 12 minutes) and with a “cyclic” reprise of the initial
fanfare theme: Insegne gloriose, Notturno sulle alpi e
Macchine e cuori (le fonderie della Fiat).
In 1989 a big group (the
American Aviation band) commissioned to one of the most famous and
academically acknowledged composers (James Barnes) a new big
piece (the Third Symphony op. 89): the result could have been a
music of big “packaging” and equal coldness; if this did not happen is
also thank to the dramatic emerging of very private memories of the
composer : the elaboration of the mourning for the loss of his daughter
Nathalie. The four traditional symphony movements (also separately
performable, with duration of about 14, 6, 13 and 7 minutes) are
therefore willing to represent the course from the darkness of
desperation to the light of rebirth and reconciliation, starting from
the “informal” beginning of the first movement (Lento – Allegro
ritmico), through the interlude of the second one (a Scherzo
not namely for the musical form and spirit, but for the “Stravinski”
rhythmic taste and the melody typical of the Anglo-Saxon world - Vaughan
Williams). Hearth of the piece is Fantasia per Nathalie (“fantasia
sul mondo in è vissuta Nathalie; il mio Addio per lei”), where
melodic expansions with full orchestra emphasis are alternated to
delicate carillons and instrumental bicinia; the final (Allegro
giocoso) alternates fanfare themes to “choral” moments of simple
harmony and quiet cantabile.
Complete different approaches
are characterising two recent pieces as In Memoriam by David
Maslanka (duration about 15 minutes) and October by Eric
Whitacre (about 8 minutes). The first piece has been commissioned by
the goliardic associations Kappa Kappa Psi and Tau Beta Sigma of the
Texas University in memory of Susan Eck, wife of Ray Lichtenwater,
conductor of university bands. The musical memory of a Bach choral (Wer
nur den lieben Gott laβt walten) is the starting point of an
elaboration looking for new languages through the use, also unusual, of
instruments; the wide “variazioni-fantasia” ends in an atmosphere of
warm force, in agreement with the 17th century hymn text: “If you but
trust in God to guide you / And place your confidence in Him, / You’ll
find Him always there beside you, / To give you hope and strength within.
/ For those who trust Gods changeless love / Build on the rock that will
not move”.
In the second piece the
evocation of the month of October (which is not for sure “the most cruel
of months” of a ... Landa desolata) leans on simple melodies inspired to
English romantics (reminding Elgar and Vaughan Williams); in the
author’s words “I worked hard to create a piece that could be
successfully performed by all of the high schools in the consortium
[that associated in order to find the funds for commissioning the piece],
yet never compromised its musical integrity. Frankly, writing ‘easy’
music is one of the hardest things I’ve ever done. I’m quite happy with
the end result, especially because I feel there just isn’t enough lush,
beautiful music written for winds.”.
The circle closes on the wagons
of the roller coaster by Dereck Bourgeois: Roller Coster,
commissioned in 2000 as opening piece (“warm up”) for taking part in an
international band contest, is from beginning to end (about 7 minutes) a
virtuosity run-up, unstopped and breathtaking.
|