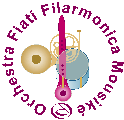Cercherò Lontana Terra
“Cercherò lontana terra
dove gemer sconosciuto;
là vivrò col cuore in guerra
deplorando il ben perduto.”
(Gaetano
Donizetti,
Don
Pasquale, 1843)

I Brani
Le migrazioni (più o meno volontarie)
hanno sempre fatto parte della storia dell’homo sapiens: un fenomeno
estremamente “plastico”, soggetto anche a variabilità improvvise. In una
sola generazione, gli Italiani sono passati, dal ricordo dei propri
padri / nonni emigrati a cercar fortuna, al confronto – per la prima
volta nella loro storia – con migliaia di immigrati delle più diverse
etnie e provenienze, fino a leggere, non in pubblicazioni
specialistiche, ma nella stampa quotidiana: «Chi non ha sentito parlare
di ventenni e trentenni che si sono trasferiti o che si stanno per
trasferire in terre lontane per cercare fortuna? Ogni anno sono circa
600-700 i giovani bergamaschi che si trasferiscono all’estero». [L’Eco
di Bergamo – 13/1/2013]
 Da quando, col Romanticismo, la musica
ha scoperto di poter essere un corrispettivo dei moti dell’anima, si è
aperta la possibilità (enorme quanto altrettanto potenzialmente
distruttiva) di essere un “altrove” rispetto alla realtà di tutti i
giorni: viandanti, pellegrini verso l’Oriente, “donne senz’ombra” (e
uomini senza immagine nello specchio …) tutti alla ricerca di una verità
spirituale negata da un mondo che non a caso proprio allora cominciava a
essere dominato dalla produzione industriale (mentre ora pare esserlo da
un’ancora più “incomprensibile” finanza globale). Se vi è un’opera come
nessuna “quarantottesca”, è Lohengrin: con baldanza
eroica, l’artista prova a riportare nella storia giustizia, bellezza e
purezza (valori ormai disponibili solo in “un altro mondo”). Da quando, col Romanticismo, la musica
ha scoperto di poter essere un corrispettivo dei moti dell’anima, si è
aperta la possibilità (enorme quanto altrettanto potenzialmente
distruttiva) di essere un “altrove” rispetto alla realtà di tutti i
giorni: viandanti, pellegrini verso l’Oriente, “donne senz’ombra” (e
uomini senza immagine nello specchio …) tutti alla ricerca di una verità
spirituale negata da un mondo che non a caso proprio allora cominciava a
essere dominato dalla produzione industriale (mentre ora pare esserlo da
un’ancora più “incomprensibile” finanza globale). Se vi è un’opera come
nessuna “quarantottesca”, è Lohengrin: con baldanza
eroica, l’artista prova a riportare nella storia giustizia, bellezza e
purezza (valori ormai disponibili solo in “un altro mondo”).
Pochi anni prima, nel 1843, era un
tenore del melodramma italiano che si proponeva di emigrare (per
delusione d’amore): era Ernesto nel Don Pasquale, non a caso opera di
ambientazione “moderna”. Però parecchio tempo doveva passare perché il
tema dell’emigrazione di massa trovasse eco nelle sale da concerto, e
non solo perché una nuova espressione artistica (il cinema) meglio si
prestava a interpretarlo. Quando si tratta di scappare, non ci si può
“portar dietro i pianoforti”: all’insegna della precarietà, qualche
violino, clarinetto, fisarmonica e soprattutto il “riuso” di melodie –
magari nate con altro scopo – da cantare per farsi coraggio durante il
viaggio e da conservare poi gelosamente a destinazione come legame con
la propria patria avara e rimpianta.
 La storia di queste melodie è
anch’essa un’avventura. Il famosissimo inno (pubblicato nel 1835)
“Amazing
Grace” fu scritto dal capitano negriero
John
Newton (1725-1807): è come se
Caronte, nel traghettare i dannati, non li bastonasse col remo, ma
li accompagnasse cantando “Grazia sorprendente, com’è dolce il suono /
che ha salvato un miserabile come me. / Ero perduto, ma ora sono
ritrovato / ero cieco, ma ora vedo”. Frank Ticheli così presenta la sua
versione per orchestra di fiati: «desideravo che riflettesse la potente
semplicità delle parole e della melodia; che fosse sincera, diretta,
onesta e che cercasse verità e autenticità senza usare armonie insolite
e astuti trucchetti. Credo che quella musica abbia il potere di condurci
in un luogo che le parole da sole non sono in grado di raggiungere». Ne
risulta una strumentazione raffinata e per nulla enfatica, nella quale
curiosamente si intrufolano richiami wagneriani di “idilli” e “mormorii
della foresta”. La storia di queste melodie è
anch’essa un’avventura. Il famosissimo inno (pubblicato nel 1835)
“Amazing
Grace” fu scritto dal capitano negriero
John
Newton (1725-1807): è come se
Caronte, nel traghettare i dannati, non li bastonasse col remo, ma
li accompagnasse cantando “Grazia sorprendente, com’è dolce il suono /
che ha salvato un miserabile come me. / Ero perduto, ma ora sono
ritrovato / ero cieco, ma ora vedo”. Frank Ticheli così presenta la sua
versione per orchestra di fiati: «desideravo che riflettesse la potente
semplicità delle parole e della melodia; che fosse sincera, diretta,
onesta e che cercasse verità e autenticità senza usare armonie insolite
e astuti trucchetti. Credo che quella musica abbia il potere di condurci
in un luogo che le parole da sole non sono in grado di raggiungere». Ne
risulta una strumentazione raffinata e per nulla enfatica, nella quale
curiosamente si intrufolano richiami wagneriani di “idilli” e “mormorii
della foresta”.
 L’emigrazione sarda nel secondo
dopoguerra, indirizzata alle attività minerarie e industriali del nord
Europa (Belgio, Olanda, Germania), ritrovò in una canzone all’amata
lontana (scritta qualche decennio prima dall’avvocato
Salvatore Sini e musicata nel 1921 da
Giuseppe Rachel, maestro della banda di Nuoro), un elemento che
univa chi era partito e chi era restato, un canto di solitudine e
sofferenza per il distacco da casa, e insieme di speranza: “Non posso
riposare, amore del cuore, / sto pensando a te ogni momento. / Non
essere triste gioiello d’oro, / né in dispiacere o in pensiero. / Se mi
fosse possibile (…) / ruberei dal cielo / il sole e le stelle e formerei
/ un mondo bellissimo per te”. Le Variazioni sinfoniche su “Non
potho reposare” di Hardy Mertens prendono spunto non solo dalla
melodia, ma anche da ciò che essa rappresenta per il mondo sardo (che il
compositore olandese ha più volte amorevolmente “rappresentato” in
musica) per dar vita a un’ampia partitura che combina la tradizione
orchestrale “colta” con elementi popolari, cantabilità distese con
ostinati ritmici. Dal punto di vista formale non si tratta di variazioni
in senso stretto, ma di una serie di “pannelli musicali”, in qualche
modo analoghi a quelli pittorici che accompagnano le narrazioni dei
cantastorie. L’emigrazione sarda nel secondo
dopoguerra, indirizzata alle attività minerarie e industriali del nord
Europa (Belgio, Olanda, Germania), ritrovò in una canzone all’amata
lontana (scritta qualche decennio prima dall’avvocato
Salvatore Sini e musicata nel 1921 da
Giuseppe Rachel, maestro della banda di Nuoro), un elemento che
univa chi era partito e chi era restato, un canto di solitudine e
sofferenza per il distacco da casa, e insieme di speranza: “Non posso
riposare, amore del cuore, / sto pensando a te ogni momento. / Non
essere triste gioiello d’oro, / né in dispiacere o in pensiero. / Se mi
fosse possibile (…) / ruberei dal cielo / il sole e le stelle e formerei
/ un mondo bellissimo per te”. Le Variazioni sinfoniche su “Non
potho reposare” di Hardy Mertens prendono spunto non solo dalla
melodia, ma anche da ciò che essa rappresenta per il mondo sardo (che il
compositore olandese ha più volte amorevolmente “rappresentato” in
musica) per dar vita a un’ampia partitura che combina la tradizione
orchestrale “colta” con elementi popolari, cantabilità distese con
ostinati ritmici. Dal punto di vista formale non si tratta di variazioni
in senso stretto, ma di una serie di “pannelli musicali”, in qualche
modo analoghi a quelli pittorici che accompagnano le narrazioni dei
cantastorie.
È una struttura musicale adottata
anche nel recentissimo brano di Giordano Bruno Ferri: «Ho scritto
Il canto della terra lontana su commissione
dell’Orchestra Mousiké di Gazzaniga e del suo direttore Savino
Acquaviva, che in precedenza aveva già diretto due miei importanti
lavori, ossia l’oratorio sulla pala di San Bernardino di Lorenzo Lotto e
l’esecuzione capitale “In tempo tagliato” sui quadri del Caravaggio.
Benché il soggetto di questa nuova composizione, l’immigrazione e la
lontananza dalla propria patria, mi fosse stato richiesto sin
dall’inizio, ho preferito non ispirarmi a quadri, romanzi, né canti o
storie popolari. Non ho inserito strumenti etnici o temi che
richiamassero più o meno esplicitamente una determinata cultura o una
zona geografica. Lo trovavo riduttivo. Ho puntato invece su un brano che
raccogliesse le suggestioni del tema, prendendo un frammento musicale di
poche note e utilizzandolo come filo conduttore per un viaggio, una
migrazione, una storia senza personaggi che fosse liberamente
interpretabile da ciascun ascoltatore. Nel brano si alternano momenti di
malinconia ad altri più sereni, momenti di tensione ad altri più solenni
e grandiosi. Il peregrinare di questo frammento vuol essere,
simbolicamente, il peregrinare dell’uomo e la sua continua ricerca di
una casa».
Scriveva un antico poeta cinese: “Dove
vado? Io vado e m’incammino verso i monti / a cercare pace per il mio
cuore solitario. / Ritorno alla mia terra natale, la mia patria! / Non
andrò più errando in paesi stranieri”. È il testo musicato dall’ultimo
Lied del
Canto della terra di
Gustav Mahler: se l’orchestra di Mahler è ben presente a chi scrive
oggi musica per orchestra di fiati e percussioni, le parole sono qui a
ricordarci, alla fine del viaggio, che emigrazione e accoglienza sono
veramente temi universali.
Disponibilità del progetto: da
maggio
2013
|