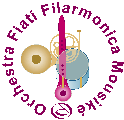Una Salda Fortezza è la mia Musica
il corale nelle recenti composizioni per orchestra di fiati
“Un cantico tedesco lento
lento
per l’aer sacro a Dio mosse le penne.
Era preghiera, e mi parea lamento,
d’un suono grave flebile solenne,
tal che sempre nell’anima lo sento
…
un desiderio di pace e d’amore,
uno sgomento di lontano esilio,
che mi faceva andare in visibilio.
E quando tacque mi lasciò pensoso
di pensieri più forti e più soavi.”
(Giuseppe
Giusti,
Sant'Ambrogio, 1845)
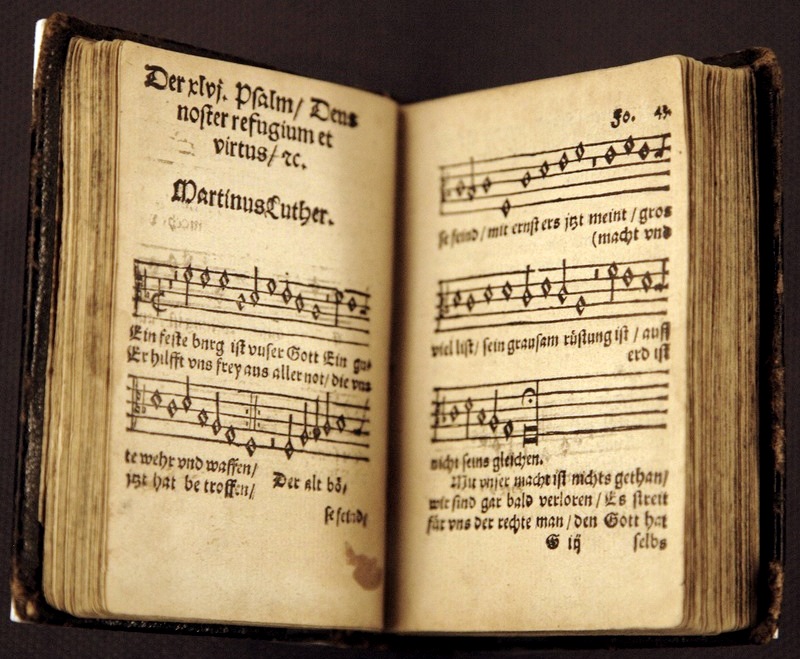
I Brani
La vicenda che
Giuseppe Giusti narra in
Sant’Ambrogio è sempre stata letta come apologo della
fratellanza fra gli oppressi, scoperta in modo inaspettato grazie agli
effetti, più o meno accidentali, di una Messa cantata (resterebbe da
chiedersi se tale effetto sarebbe stato possibile anche 3 anni dopo,
sotto il giogo della Restaurazione …).
Prima una musica italiana, “su, di
verso all’altare, un suon di banda” (è il coro dei
Lombardi di
Verdi), poi, “tutta un’altra musica”, non ci viene detto quale,
perché non la si conosce (o forse la si vorrebbe rifiutare?). Una musica
che esprime un’identità diversa dalla nostra, cantata da un popolo
diverso da noi, che però riusciamo a comprendere e accettare (ci lascia
“pensosi”); è legata a un’occasione pubblica e rituale, ma ci trasmette
anche sentimenti individuali; è intonata non da cantori professionali,
ma da semplici soldati; forse non ha neanche un autore, ma può stare a
fianco della musica “d’arte”.
Il poeta fiorentino non fa del
generico sentimentalismo, ma ci presenta gli elementi di una vera e
propria analisi musicale (perché sorprenderci? Anche
Mazzini scrisse acutamente sul melodramma italiano!): gli elementi
sono quelli del
corale
protestante.
Si tratta di una musica saldamente
legata alle singole comunità locali e, in particolare, alle esigenze di
partecipazione attiva al culto di un popolo, che – come legge
direttamente la
Bibbia
– così leggerà la musica e la canterà (se possibile, a 4 voci). Un segno
identitario fortissimo, quindi, se non fosse che fin dall’inizio le
melodie spesso non sono originali, ma hanno la provenienza più
disparata: dai
canti gregoriani a quelli dei “chierici erranti”, dagli
Hussiti
ai
Lanzichenecchi, fino ad autori che hanno contributo al genere
(grazie a opportuno cambio del testo!) in modo del tutto involontario,
come il caravaggino
Giovanni Giacomo Gastoldi col balletto L’innamorato (“A
lieta vita / Amor ci invita”). Non solo, altrettanto spesso, le melodie
si sono poi stabilite nei culti di tutte le religioni cristiane: ad
esempio, tra quelle utilizzate dalle composizioni in programma, la sola
Ein’ feste Burg (testo e musica di
Lutero) non è intonata anche nelle chiese cattoliche (sarebbe come
pensare di suonare la Marche pontificale di
Gounod in una chiesa evangelica …).
Una forma semplice, che però si presta
a una lunga serie di elaborazioni “autorali” complesse, non solo in
campo vocale, ma ancor più in quello strumentale, dall’organo (preludi,
toccate,
fughe,
fantasie, arie spirituali ornate,
variazioni …) alle grandi pagine orchestrali (cantate,
sinfonie
…).
Un momento rituale, che però scopre,
già a tempi di
Bach, anche una vocazione all’espressione della meditazione e del
sentimento individuale (si pensi, come esempio finale, ai corali per
organo di
Brahms).
È il momento di tornare a quella
“banda” di cui scriveva il Giusti; i corali e le recenti musiche per
orchestra di fiati e percussioni non solo hanno in comune una storia di
forme musicali, ma condividono la partecipazione “diretta”
all’esecuzione e un’espressione che tende all’universalità.
Di
Jacob de Haan,
si basa sul Corale “Sollt’ ich meinem Gott nicht singen?”
(“Come potrei non cantare il mio Dio?”) di
Johann Schop, compositore tedesco del XVII secolo. Scritta in
occasione del Concorso
Mondiale di Kerkrade del 1997, si apre come un brioso preludio (con
varianti della melodia) prima di presentare il corale nella sua forma
originaria e di concludersi con un’ancor più brillante toccata.
E' stata commissionata a
Philip Sparke
dalla Fanfare “Prins Hendrik” di Aalst in occasione del centenario di
fondazione (2004). Il titolo si spiega col fatto che la cittadina
olandese è posta tra due fiumi (affluenti del
Dommel); l’utilizzo del
corale di Lutero (“Una salda fortezza”) è invece un tributo alla
religiosità della comunità. Dopo una breve e vivace introduzione, il
corale è presentato a turno dalle varie sezioni strumentali e dà luogo a
quattro variazioni, organizzate quasi come i movimenti di una sinfonia
classica. La prima variazione è un moto perpetuo basato sulle 3 note
ripetute che aprono la melodia, che poi divengono l’accompagnamento a un
tema più melodico. La seconda variazione è in carattere di marcia,
mentre la terza è il “tempo lento”, che da una figurazione grave e
“sinistra” conduce a una “esplosiva” esposizione dell’intera melodia. La
quarta variazione è una fuga, con conclusiva ripresa dell’intero corale
e rapida coda, basata sulla prima variazione.
E' stata commissionata a
David
Maslanka nel 1993 da una “cordata” di orchestre a fiato guidata
dall’ensemble
"Symphonic Wind" dell'Università di Austin, Texas. È un’ampia composizione 919 battute,
organizzata in diverse libere sezioni, piuttosto che negli abituali
movimenti delle sinfonie classiche e romantiche. Oltre che melodie
originali dal carattere di inno, utilizza 2 corali bachiani,
“Wer
nur den lieben Gott läßt walten” (“Se ti affidi all’amore di Dio”)
e “Christus, der uns selig macht” (“Cristo, colui che ci rende
beati”), e il Salmo
“Old Hundreth”, la cui musica è attribuita
a
Loys Bourgeois (sec. XVI), mentre il testo è quello del
Salmo n. 100
(“Acclamate al Signore, genti tutte della Terra”).
“Old Hundreth” fu suonato da
una
fanfara di ottoni al termine delle cerimonie funebri di
Abramo
Lincoln, il 28 aprile 1865: secondo una testimonianza dell’epoca,
Lincoln composto nella bara aveva “un’espressione di gioia, di sollievo,
come di liberazione da un peso inimmaginabile, un’espressione che poche
altre volte ebbe in vita, come quando, dopo una grande calamità, aveva
raggiunto una grande vittoria”. Maslanka considera Lincoln una figura
ancor oggi attuale: “da un caos ribollente ha forgiato una nuova idea
unificante, l’unità della razza umana” e quindi, per estensione,
“l’unità di ogni vita con ogni materia, con ogni energia e col muto e
apparentemente impenetrabile mistero delle nostre origini. Dal caos e
dalla feroce unione degli opposti nascono nuova vita e speranza”. Il
Salmo recita “entrate nel suo tempio con canti, nei suoi cortili con
inni di lode”: la musica cerca di esprimere “i valori umani di
trasformazione e rinascita, fondamentali nella nostra caotica epoca”.
Gli Autori
|
Nato nel 1959 a
Heerenveen (Olanda),
si è diplomato in organo e pedagogia musicale al Conservatorio di
Leeuwarden, dove ora è docente di strumentazione. È considerato tra gli
autori ed arrangiatori più apprezzati nel campo della musica per
orchestre di fiati: le sue composizioni (tra cui la famosissima
Oregon) sono eseguite in tutto il mondo.
|
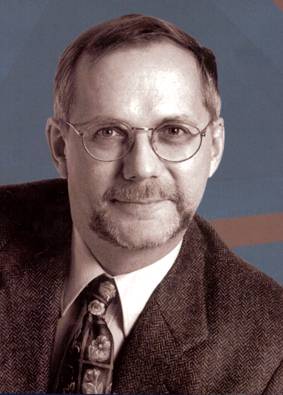
Nato a
Londra nel 1952, ha studiato
composizione, tromba e pianoforte al
Royal College of Music, dove si è
presto interessato alla musica per strumenti a fiato. Per tre volte
vincitore del concorso di composizione per orchestra di fiati della BBC,
ha scritto molti brani d’obbligo di concorsi internazionali per
complessi di ottoni; nel 1997
Dance Movements (commissione
della Banda dell’Aeronautica
Militare USA) ha vinto il premio Sudler. Come
direttore e giurato opera in numerosi Paesi europei, in Australia, Nuova
Zelanda, Giappone, USA.
|
|
E' nato a
New Bedford (Massachussetts)
nel 1943. Ha studiato composizione all’Oberlin College, perfezionandosi
al Mozarteum di Salisburgo e laureandosi con
H. Owen Reed all’Università
del Michigan. Ha insegnato presso l’Università di New York, il
Sarah
Lawrence College, il
Kingsborough Community College. Ora vive a
Missoula,
nel Montana. Tra le sue composizioni più note per orchestra di fiati
A Child’s Garden of Dream, il
Concerto per pianoforte, le
Sinfonie, la
Messa con coro, voci bianche e organo,
In
memoriam (che la Filarmonica Mousiké ha eseguito nel 2007).
|
I Corali
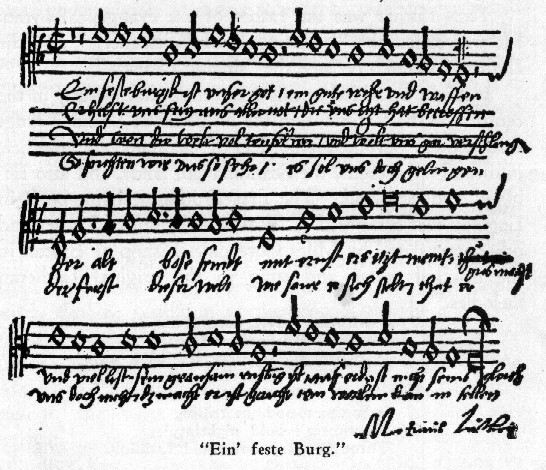
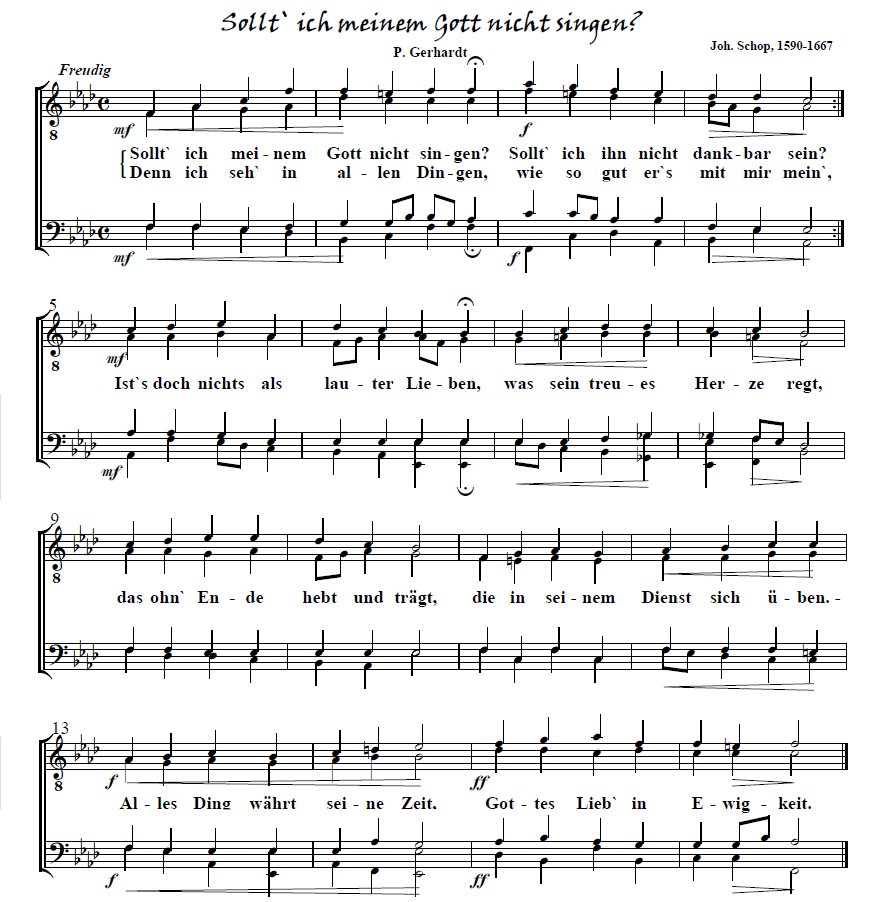
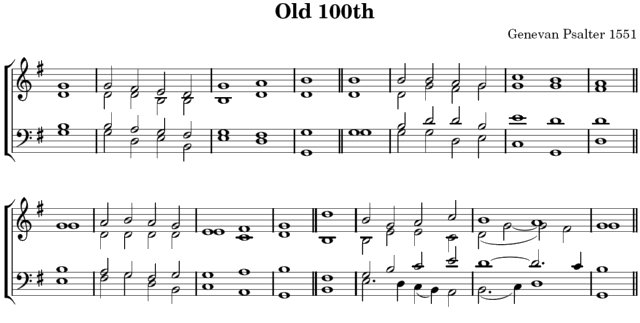
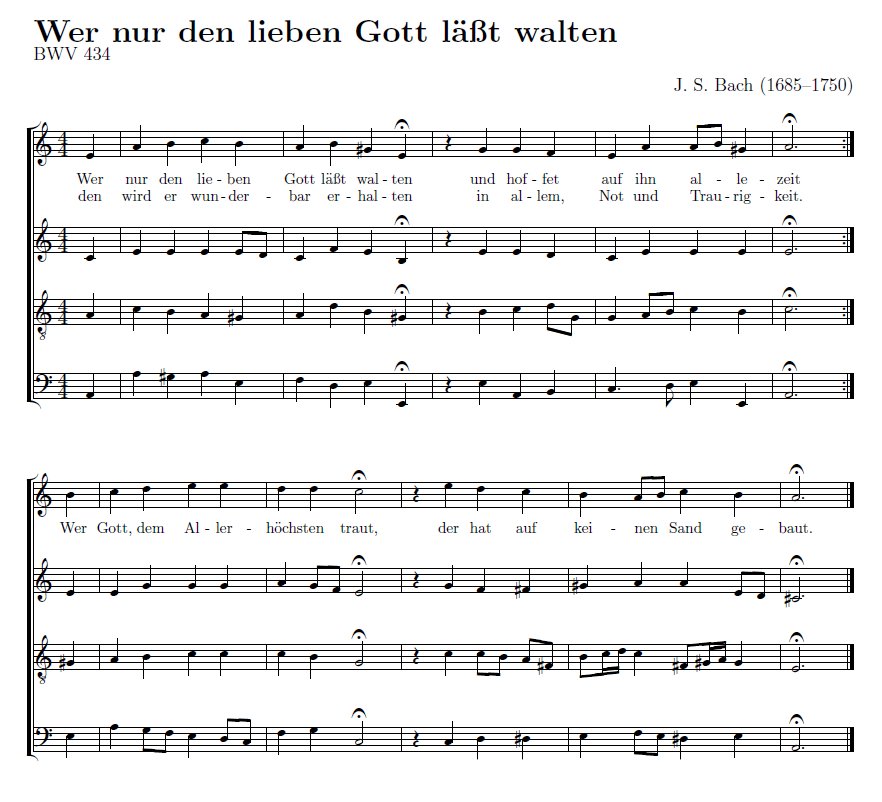
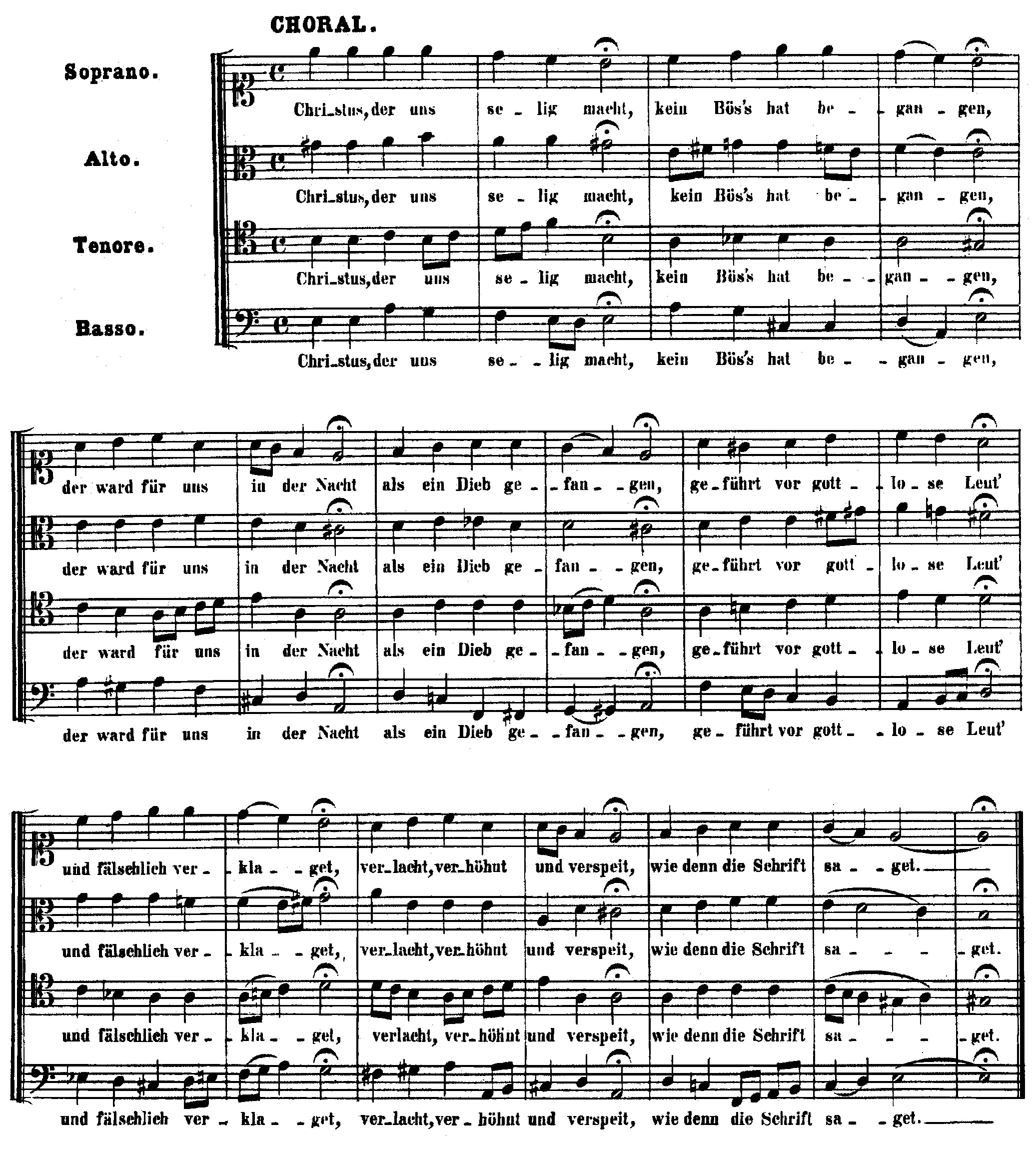
Disponibilità del progetto: da
giugno
2011.
|